La R2P è una delle caratteristiche più importanti della politica globale e delle relazioni internazionali (RI) del dopo Guerra Fredda, in relazione al rapporto tra guerra e politica. È stata formalizzata nel 2005, concentrandosi sui casi in cui la comunità internazionale (ONU) deve intervenire per la protezione umana. La R2P è stata ufficialmente approvata dalla comunità internazionale con decisione unanime dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come principio durante il Vertice Mondiale delle Nazioni Unite del 2005. Tale accordo è stato disciplinato nei paragrafi 138-140 dei documenti di tale Vertice Mondiale. Vi sono tre decisioni cruciali riguardanti il principio della R2P:
- 1) Ogni Stato è responsabile della protezione della propria popolazione, in generale, non solo dei cittadini ma più in generale di tutti i residenti che vivono nel suo territorio, da quattro crimini: a) genocidio, b) crimini di guerra, c) crimini contro l'umanità e d) pulizia etnica.
- 2) La comunità internazionale ha la responsabilità di incoraggiare e assistere gli Stati affinché si assumano la responsabilità fondamentale di proteggere i propri residenti dai quattro crimini definiti nella prima decisione.
- 3) Nel caso, tuttavia, in cui le autorità statali "manifestino" la loro inadempienza nel proteggere i propri residenti dai quattro crimini, la comunità internazionale ha la responsabilità morale di adottare misure tempestive e decisive caso per caso. In linea di principio, tali azioni includono sia misure coercitive che non coercitive, basate sui Capitoli VI-VIII della Carta delle Nazioni Unite.
La R2P è stata, ad esempio, invocata in circa 45 Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come le Risoluzioni 1970 e 1973 sulla Libia del 2011. Ciononostante, il principio della R2P è direttamente connesso al principio della Sovranità Responsabile, ovvero l'idea che la sovranità di uno Stato sia subordinata al trattamento riservato dalle autorità statali ai propri cittadini, fondata sulla convinzione che l'autorità dello Stato derivi in ultima analisi da individui sovrani.
Essendo un principio molto complesso, dal punto di vista della comunità internazionale, è tuttavia generalmente accettato che il consenso prevalente sia che la R2P sia meglio intesa come un quadro sfaccettato o una norma giuridica e morale complessa che incarna molte componenti diverse ma correlate. Riguardo a questo tema, nel 2009, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha suddiviso la R2P in tre pilastri, che hanno avuto un'importante influenza nel dibattito successivo:
- A. Il Pilastro I si riferisce alle responsabilità interne degli Stati di proteggere i propri cittadini dai quattro crimini.
- B. Il Pilastro II riguarda la responsabilità della comunità internazionale di fornire assistenza internazionale con il consenso dello Stato bersaglio.
- C. Il Pilastro III si concentra sulla "risposta tempestiva e collettiva", in quanto la comunità internazionale intraprende azioni collettive attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per proteggere le persone dai quattro crimini, ma senza il consenso dello Stato bersaglio, ovvero delle sue autorità governative.
Tuttavia, sebbene gli Stati non abbiano formalmente aderito a questa struttura dell'approccio a tre pilastri, essi contribuiscono comunque a distinguere tra le diverse forme di intervento R2P. Tra gli altri esempi, l'assistenza internazionale in Mali o in Sud Sudan è stata fornita nell'ambito della R2P e con il consenso dei governi di Mali e Sud Sudan (riflettendo l'azione del Secondo Pilastro), ma l'intervento militare in Libia nel 2011 è stato effettuato senza il consenso del governo libico (riflettendo l'operazione del Terzo Pilastro).
Ciò nonostante, la giustificazione più ampia per l'intervento umanitario nell'ambito del quadro giuridico internazionalmente riconosciuto della R2P è quella di fermare o prevenire il genocidio, considerato il peggior crimine contro l'umanità possibile: il "crimine dei crimini". Ciononostante, nella pratica, è molto difficile fornire una giustificazione di "giusta causa" coerente e affidabile per l'intervento umanitario internazionale nell'ambito del quadro giuridico della R2P. Questo è proprio il motivo per cui il fenomeno del genocidio è solitamente inteso come un atto deliberato o persino un programma pianificato di uccisioni di massa e distruzione di un intero gruppo umano o di una sua parte, basato su motivazioni etniche, ideologiche, politiche, religiose o simili. Probabilmente, il tentativo più autorevole di stabilire i principi dell'intervento militare internazionale in relazione alla R2P è quello della Commissione Internazionale sull'Intervento e la Sovranità Statale (ICISS), proposta nel 2000 dal Canada:
- 1) Perdita di vite umane su larga scala. Può essere, tuttavia, reale o propagata, con intento genocida o meno, ovvero il prodotto di diverse cause, come un'azione deliberata di polizia e militari, la negligenza o l'incapacità di agire da parte dello Stato, o una situazione di stato fallito (il cosiddetto "stato fallito/canaglia") (ad esempio, il genocidio ruandese del 1994).
- 2) Pulizia etnica su larga scala. Effettivi o presunti, siano essi perpetrati tramite uccisioni, espulsioni forzate, atti di terrorismo o stupri (ad esempio, l'attuale olocausto palestinese a Gaza).
Tuttavia, una volta stabiliti i criteri per l'intervento umanitario, la domanda successiva è immediatamente all'ordine del giorno: chi dovrebbe decidere quando tali criteri sono soddisfatti? In altre parole: chi ha la "legittima autorità" per autorizzare un intervento militare per scopi umanitari? Da un punto di vista generale, la risposta universalmente accettata a queste domande è che l'unico Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto organo di sicurezza globale, è autorizzato a dare "via libera" all'intervento militare internazionale (ciò che non è stato fatto, ad esempio, nel caso dell'intervento della NATO contro la Repubblica Federale di Jugoslavia nel 1999 e, pertanto, questo intervento di 78 giorni è un puro esempio di aggressione militare contro uno Stato sovrano). Questa conclusione riflette, di fatto, il ruolo delle Nazioni Unite come fonte fondamentale del diritto internazionale, a cui fa seguito la responsabilità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la tutela della sicurezza e della pace internazionale.
Tuttavia, uno dei problemi cruciali è diventato il fatto che, in pratica, potrebbe essere molto difficile ottenere l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per l'intervento militare, proprio perché ci sono cinque grandi potenze con diritto di veto (ad esempio, gli Stati Uniti hanno sempre fatto ricorso al diritto di veto per bloccare qualsiasi azione anti-israeliana del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite). Alcune di esse, o tutte, potrebbero essere più preoccupate per le questioni di potere globale, i loro obiettivi geopolitici o di altro tipo, ecc., che per le reali preoccupazioni umanitarie. Ciononostante, i principi su cui si fonda l'idea della R2P hanno riconosciuto tale problema richiedendo che l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite debba essere ottenuta prima dell'inizio di qualsiasi intervento militare, ma allo stesso tempo accettano che debbano essere disponibili opzioni alternative qualora il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite respinga una proposta di intervento militare o non riesca a trattarla in un tempo ragionevole. Secondo la R2P, queste possibili alternative prevedono che una proposta di intervento umanitario venga presa in considerazione dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in una Sessione Speciale di Emergenza o da un'organizzazione regionale o subregionale (ad esempio, l'Unione Africana). Tuttavia, nella pratica, ad esempio, la NATO è stata (abusata) utilizzata in tali questioni, fungendo da macchina militare che effettua interventi militari, come nella Repubblica Federale di Jugoslavia nel 1999 o in Afghanistan nel 2001, e successivamente per mantenere l'ordine in quei territori occupati.
Da un certo punto di vista, il valore della R2P è ancora contestato, soprattutto tra i teorici della politica globale e delle Relazioni Internazionali. Tuttavia, i suoi sostenitori difendono il principio della R2P in base ai suoi sette aspetti (positivi) cruciali:
- 1) Il principio riconsidera la nozione di sovranità proprio perché richiede che la sovranità statale (indipendenza) sia, di fatto, una responsabilità morale piuttosto che un diritto pratico. In altre parole, lo Stato deve meritare di essere trattato come sovrano mantenendo tutti i doveri internazionali, incluso il principio di responsabilità per la protezione (R2P).
- 2) Il principio si concentra sui deboli piuttosto che sui potenti, affrontando il diritto delle vittime a essere protette, ma non il diritto delle autorità statali a intervenire.
- 3) Il principio di responsabilità per la protezione (R2P) stabilisce una linea rossa piuttosto chiara, individuando quattro crimini come segnale per un'azione e un intervento internazionale, se necessario.
- 4) Il sostegno consensuale alla R2P tra gli Stati è molto significativo, poiché tale consenso contribuisce alla comprensione internazionale della condotta giusta, in particolare per quanto riguarda la questione della "Guerra Giusta" nel caso di un intervento militare internazionale.
- 5) Il principio è più ampio in termini di portata operativa rispetto alla forma pura e alla comprensione dell'intervento umanitario, il che pone una falsa scelta tra due estremi: non fare nulla o andare in guerra. Tuttavia, si sostiene che la R2P superi tale scelta semplicistica delineando l'ampia gamma di misure coercitive e non coercitive che, in pratica, possono essere utilizzate per incoraggiare, assistere e, se necessario, costringere gli Stati ad assumersi le proprie responsabilità in base al diritto e agli standard internazionali.
- 6) Sebbene non aggiunga nulla di nuovo al diritto internazionale, il principio della R2P richiama l'attenzione su un'ampia gamma di responsabilità giuridiche preesistenti e, di conseguenza, aiuta la comunità internazionale a concentrare la propria attenzione e responsabilità sulla crisi reale.
- 7) Per quanto riguarda il caso dell'Iraq del 2003, la R2P è diventata, almeno agli occhi degli occidentali, un principio importante nel ribadire che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è il principale autorizzatore legale di qualsiasi uso della forza previsto dal Pilastro III. Tuttavia, la stessa politica non ha funzionato nel caso dell'aggressione della NATO alla Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) nel 1999. Il motivo per cui il principio R2P non viene utilizzato dalla comunità internazionale contro la pulizia etnica israeliana dei palestinesi di Gaza è proprio il fatto che la Cisgiordania di Israele è parte degli Stati Uniti.
Cos'è un Intervento Militare Umanitario (HMI)?
Il principio della R2P è direttamente collegato alla questione dell'intervento militare umanitario pratico, se necessario. Secondo il concetto accademico ampiamente accettato di intervento militare umanitario (HMI), si tratta di un tipo di intervento militare con finalità principalmente umanitarie, ma non strategiche o geopolitiche e obiettivi finali. Ciononostante, il termine stesso è diventato molto contestato ed estremamente controverso, poiché, fondamentalmente, dipende dalle sue diverse interpretazioni e interpretazioni. In sostanza, il problema è
rappresentare l'intervento militare come umanitario affinché sia legalmente legittimo e moralmente difendibile.
Ciò nonostante, nella pratica, l'uso del termine HMI è sicuramente valutativo e soggettivo. Ciononostante, alcuni HMI, almeno in termini di intenzioni, possono essere classificati come umanitari se sono motivati principalmente dal desiderio di prevenire danni a un gruppo di persone, inclusi il genocidio e la pulizia etnica. In pratica, dobbiamo comprendere che nella maggior parte dei casi di HMI, le motivazioni per tale intervento sono miste: dichiarative e nascoste. La valutazione dell'intervento umanitario (HMI) può essere effettuata in termini di risultati puri: l'HMI è realmente umanitario solo se si traduce in un miglioramento concreto delle condizioni, e in particolare in una riduzione della sofferenza umana.
Esistono tre atteggiamenti decostruttivi riguardo all'HMI:
- 1) Presentando gli HMI come umanitari, si fornisce loro un quadro completo di giustificazione morale e legittimità, il che significa legittimità. Il termine stesso "HMI", quindi, contiene in sé qualcosa di proprio, così come deve essere l'intervento che serve gli interessi dell'umanità riducendo la mortalità e forme cruciali di sofferenza fisica e mentale.
- 2) Il termine stesso intervento si riferisce a diverse forme di ingerenza negli affari interni di altri (in linea di principio, degli Stati). Pertanto, il termine nasconde il fatto che gli interventi (militari) in questione sono azioni militari che comportano l'uso della forza e della violenza. Di conseguenza, il termine "intervento militare umanitario" (HMI) è più oggettivo e, pertanto, preferibile.
- 3) La nozione di intervento umanitario può riprodurre significative asimmetrie di potere. I poteri di intervento (in pratica, la NATO e gli stati membri della NATO) possiedono potere militare e giustificazione morale formale, mentre i gruppi umani che necessitano di protezione (in pratica, nei paesi in via di sviluppo) vengono presentati propagandisticamente come vittime che vivono in condizioni di caos e di Medioevo. Di conseguenza, il termine HMI, di fatto, sostiene la nozione di occidentalizzazione come modernizzazione o addirittura, di fatto, americanizzazione.
Più precisamente, HMI è l'ingresso in uno stato straniero o in un'organizzazione internazionale da parte delle forze armate con il compito dichiarato di proteggere i residenti da una persecuzione reale o presunta o dalla violazione dei loro diritti umani (e in alcuni casi minoritari). Ad esempio, l'intervento militare russo in Cecenia negli anni '90 si è reso necessario per tutelare i diritti della minoranza ortodossa russa in un contesto musulmano ceceno. Tuttavia, le linee giuridiche e politiche dell'HMI sono ambigue, soprattutto nei casi di giustificazione morale per incursioni armate in stati colpiti da crisi al fine di realizzare obiettivi strategici e geopolitici, come nel caso dell'intervento militare della NATO contro la Repubblica Federale di Jugoslavia nel 1999. Tutti i sostenitori contrari dell'HMI citano la Carta delle Nazioni Unite, che afferma chiaramente che tutti gli stati membri delle Nazioni Unite si astengono nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi stato. Tuttavia, d'altra parte, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è autorizzato a intervenire specificamente. La giustificazione dell'HMI al fine di proteggere la vita e i diritti delle persone è ancora oggetto di dibattito su quando sia giusto intervenire e quando no.
Infine, per quanto riguarda l'HMI, le questioni cruciali rimangono:
- 1) Bilanciamento dei diritti delle minoranze e della maggioranza;
- 2) Quantità di morti e danni accettabili durante l'intervento militare umanitario (il cosiddetto "danno collaterale");
- 3) Come ricostruire le società dopo l'intervento militare umanitario?
In effetti, entrambi i concetti, R2P e HMI, sono direttamente collegati al concetto di sicurezza umana. Le origini del concetto risalgono al Rapporto sullo Sviluppo Umano delle Nazioni Unite del 1994. Il rapporto affermava che, sebbene la maggior parte degli stati della comunità internazionale garantisse la libertà e i diritti dei propri residenti, gli individui rimanevano comunque vulnerabili a diversi livelli di minacce come povertà, terrorismo, malattie o inquinamento.
Il concetto di sicurezza umana è stato sostenuto dagli studiosi accademici come l'idea che gli individui, in contrapposizione agli stati, dovrebbero essere l'oggetto di riferimento della sicurezza nelle Relazioni Internazionali e negli studi sulla sicurezza. A loro avviso, sia la sicurezza umana che gli studi sulla sicurezza devono mettere in discussione la visione incentrata sullo stato della sicurezza internazionale e delle Relazioni Internazionali.
L'intervento militare umanitario (HMI) funziona nella pratica?
Per quanto riguarda qualsiasi tipo di intervento militare umanitario (HMI) nel quadro morale e giuridico della R2P, la domanda centrale è diventata: i benefici dell'intervento militare umanitario superano i suoi costi? O, per porre la domanda in modo diverso: la R2P salva effettivamente vite umane?
In sostanza, la questione cruciale è valutare l'HMI non dal punto di vista delle sue motivazioni/intenzioni morali, o persino in termini di quadro giuridico internazionale, ma piuttosto dal punto di vista dei suoi effetti diretti (a breve termine) e indiretti (a lungo termine) da diversi punti di vista (politico, economico, costi umani, culturali, ambientali, ecc.). Tuttavia, per risolvere questo problema è necessario confrontare i risultati reali con quelli che si verificherebbero in determinate circostanze, di fatto ipotetiche; ad esempio, cosa accadrebbe sul campo se la R2P non si verificasse? Tuttavia, tali circostanze ipotetiche non possono essere dimostrate nella realtà, come ad esempio sostenere che un precedente ed efficace intervento dell'HMI in Ruanda nel 1994 salverà centinaia di migliaia di vite o che, senza l'intervento militare della NATO nei Balcani nel 1999, gli albanesi di etnia albanese in Kosovo subiranno espulsioni di massa e soprattutto pulizia etnica/genocidio da parte delle forze di sicurezza jugoslave. Ciononostante, nella pratica, ad esempio, l'intervento militare della NATO nei Balcani nel 1999 divenne il fattore scatenante della rappresaglia serba contro la popolazione albanese in Kosovo. In altre parole, l'aggressione della NATO in Kosovo nel 1999 raggiunse l'obiettivo iniziale di espellere la polizia serba e l'esercito jugoslavo dalla provincia, ma allo stesso tempo favorì un massiccio esodo della popolazione di etnia albanese (tuttavia, gran parte di questo "esodo" fu organizzato dall'Esercito di Liberazione del Kosovo albanese per uno show televisivo sui media corporativi occidentali) e fornì un'armatura postbellica per la vera e propria pulizia etnica dei serbi del Kosovo da parte degli albanesi locali per i successivi 20 anni. In questo particolare caso dell'HMI, l'azione militare R2P ha provocato una catastrofe umanitaria, il che significa che ha effetti assolutamente controproducenti rispetto al suo obiettivo iniziale (umanitario/morale).
Tuttavia, si può affermare, almeno dal punto di vista occidentale, che vi sono alcuni esempi dell'HMI che si sono rivelati benefici, come l'istituzione di una "no-fly zone" nel nord dell'Iraq nel 1991, che non solo ha impedito rappresaglie e massacri dei curdi dopo la loro rivolta (sostenuta dagli Stati Uniti e dai suoi alleati), ma allo stesso tempo ha permesso al territorio popolato dai curdi di sviluppare un alto grado di autonomia (ma non come quella di cui godettero gli albanesi del Kosovo in Jugoslavia dal 1974 al 1989). In entrambi i casi, Iraq nel 1991 e Jugoslavia nel 1999, entrambe le operazioni sono state condotte da attacchi aerei della NATO che hanno causato un numero significativo di vittime civili sul terreno e un numero minimo tra gli aggressori. Ad esempio, le stime relative alle vittime civili e combattenti uccise in Kosovo nel 1999 ammontano a 5.700, secondo fonti serbe (le vittime nella Serbia centrale e settentrionale non vengono prese in considerazione in questa occasione). La propaganda accademica occidentale sostiene che l'intervento militare occidentale in Sierra Leone sia stato, in sostanza, efficace, in quanto ha posto fine a una guerra civile decennale, costata fino a quel momento circa 50.000 vite, e ha gettato le basi per elezioni parlamentari e presidenziali democratiche nel 2007.
Esistono molti altri interventi militari R2P che, di fatto, sono falliti o sono stati molto meno efficaci, sollevando quindi interrogativi sul loro scopo. L'HMI sotto l'egida legale delle forze di pace delle Nazioni Unite, in alcune occasioni, ha fallito in concomitanza con catastrofi umanitarie (Kosovo dopo il giugno 1999, Congo), mentre alcuni HMI sono stati rapidamente abbandonati a se stessi (Somalia). Tuttavia, diversi interventi R2P si sono conclusi con una prolungata lotta controinsurrezionale (Iraq o Afghanistan). Questo è il problema cruciale che si sta ponendo riguardo all'efficacia dell'HMI/R2P: tali interventi militari, nella pratica, possono portare più danni che benefici. Uno degli esempi classici e dei problemi relativi a questo problema è che cambiare alcuni regimi autoritari con l'impiego di forze di occupazione straniere, in molti casi, non fa altro che aumentare la tensione politica e provocare vere e proprie guerre civili, che, di conseguenza, sottopongono la popolazione comune del Paese a una situazione di costante guerra civile e sofferenza. In linea di principio e per esperienza pratica, se la lotta civile deriva da un effettivo collasso del governo, interventi stranieri di qualsiasi tipo possono solo peggiorare la situazione politica interna, ma non migliorarla.
Sebbene la stabilità politica, la governance fondata sui principi democratici e il rispetto dei diritti umani universali siano obiettivi teoricamente e moralmente auspicabili, in pratica non è sempre possibile per qualsiasi tipo di entità esterna imporli o farli rispettare. Pertanto, l'intervento militare umanitario (HMI) deve essere interpretato in una prospettiva di risultati a lungo termine e non come il risultato della pressione dell'opinione pubblica o dei politici che impongono un intervento. È noto che alcuni interventi militari umanitari (HMI) sono semplicemente falliti a causa di sforzi di ricostruzione mal pianificati o di un'insufficiente fornitura di diverse tipologie di risorse per la ricostruzione. Di conseguenza, il principio HMI/R2P pone l'accento non solo sulla responsabilità di proteggere, ma anche sulla responsabilità di prevenire e sulla responsabilità di ricostruire dopo l'intervento.
L'intervento militare umanitario (HMI) è giustificato?
Negli ultimi 30 anni, l'HMI è diventato uno degli argomenti più controversi sia nelle Relazioni Internazionali che nella politica mondiale. Esistono due approcci diametralmente opposti alla pratica dell'HMI: 1) È evidente che le relazioni internazionali siano guidate da nuove e più accettabili sensibilità cosmopolite; e 2) Le HMI sono, in linea di principio, molto fuorvianti, motivate politicamente e geopoliticamente e, infine, moralmente confuse.
Le argomentazioni principali a favore dell'HMI come caratteristica positiva delle Relazioni Internazionali possono essere riassunte nei seguenti cinque punti:
1) L'HMI si fonda sulla convinzione che esista un'umanità comune, il che implica l'atteggiamento secondo cui le responsabilità morali non possono essere limitate solo al proprio popolo, ma piuttosto all'intera umanità.
2) La R2P è rafforzata dal riconoscimento della crescente interconnessione e interdipendenza globale e, pertanto, le autorità statali non possono più comportarsi come se fossero isolate dal resto del mondo. Di conseguenza, l'HMI è giustificato come un interesse personale illuminato, ad esempio per fermare la crisi dei rifugiati, che può provocare seri problemi politici all'estero.
3) Il fallimento dello Stato che provoca problemi umanitari avrà implicazioni estreme per l'equilibrio di potere regionale e, pertanto, creerà instabilità in termini di sicurezza. Tale atteggiamento fornisce il contesto geopolitico che consente agli Stati limitrofi di partecipare all'HMI, con le grandi potenze che scelgono di intervenire formalmente per prevenire un possibile scontro militare regionale.
4) L'HMI può essere giustificato nel contesto politico in cui la popolazione sta soffrendo, in quanto non dispone di un modo democratico per eliminare le proprie difficoltà. Di conseguenza, l'HMI può aver luogo al fine di rovesciare il regime politico autoritario della dittatura e, quindi, promuovere la democrazia politica attraverso la promozione dei diritti umani e di altri valori democratici.
5) L'HMI può non solo fornire prove concrete dei valori condivisi dalla comunità internazionale come la pace, la prosperità, i diritti umani o la democrazia politica, ma può anche fornire linee guida sul modo in cui l'autorità statale deve trattare i propri cittadini nel quadro della cosiddetta "sovranità responsabile".
Tuttavia, le argomentazioni principali contro l'HMI sono:
- 1) L'intervento umanitario è, di fatto, un'azione contraria al diritto internazionale, in quanto il diritto internazionale autorizza chiaramente l'intervento solo in caso di legittima difesa. Tale autorizzazione si fonda sul presupposto che il rispetto dell'indipendenza dello Stato costituisca il fondamento dell'ordine internazionale e delle Riforme Internazionali. Anche se l'intervento umanitario è formalmente consentito dal diritto internazionale in una certa misura per scopi umanitari, il diritto internazionale, in questo caso, è confuso e fondato sulle regole indebolite dell'ordine politico globale, degli affari esteri e delle Riforme Internazionali.
- 2) Dietro l'intervento umanitario vi è, di fatto, l'interesse nazionale, ma non un reale interesse alla protezione delle norme umanitarie internazionali. Gli Stati sono sempre motivati principalmente da preoccupazioni di interesse nazionale e, pertanto, la loro affermazione formale che l'intervento umanitario sia presumibilmente motivato da considerazioni umanitarie è un esempio di inganno politico. Tuttavia, se le azioni umanitarie sono realmente umanitarie, lo Stato in questione sta mettendo a rischio i propri cittadini per salvare degli stranieri, violando il proprio interesse nazionale.
- 3) Nella pratica dell'HMI o della R2P possiamo trovare molti esempi di doppi standard. Si tratta della pratica di urgenti emergenze umanitarie in un contesto in cui l'HMI viene esclusa o non viene mai presa in considerazione. Ciò accade per diverse ragioni: nessun interesse nazionale in gioco; assenza di copertura mediatica; l'intervento è politicamente impossibile, ecc. Una situazione del genere, di fatto, confonde l'HMI sia in termini politici che morali.
- 4) L'HMI si fonda, nella maggior parte dei casi pratici, su un'immagine politicizzata di conflitto politico tra "buoni e cattivi". Di solito, è stata una conseguenza dell'esagerazione dei crimini di guerra sul campo. Allo stesso tempo, ignora le complessità morali che sono parte integrante di tutti i conflitti internazionali e nazionali. In realtà, il tentativo di semplificare qualsiasi crisi umanitaria contribuisce a spiegare la tendenza alla cosiddetta "deriva della missione" e al fallimento degli interventi.
- 5) L'HMI è visto in molti casi come un imperialismo culturale, basato su valori essenzialmente occidentali in materia di diritti umani, che non sono applicabili in altre parti del mondo. Le differenze religiose, storiche, culturali, sociali e/o politiche rendono impossibile la creazione di linee guida universali per il comportamento delle autorità statali.
Di conseguenza, il compito di stabilire una soglia di "giusta causa" per l'HMI nel quadro della R2P risulta irraggiungibile.
Ex professore universitario
Vilnius, Lituania
Ricercatore presso il Centro di Studi Geostrategici
Belgrado, Serbiawww.geostrategy.rs
Ringrazio il Dr. Vladislav B. Sotirovic, per aver inviato questo suo articolo da tradurre e pubblicare sul nostro sito. Alba Canelli
Segui @vocidallastrada anche su Telegram
👉🏼 https://vocidallastrada.substack.com/
👉🏼 https://vocidallastrada.substack.com/
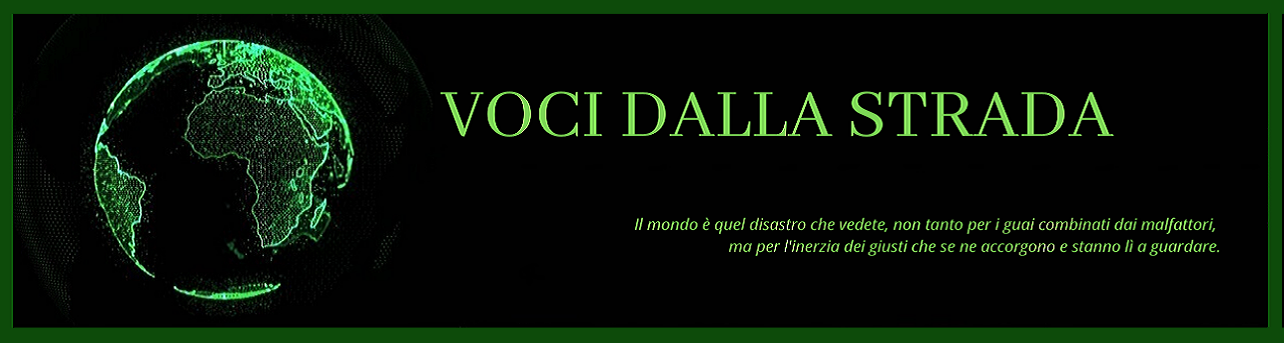


Nessun commento:
Posta un commento
Avvertenze da leggere prima di intervenire sul blog Voci Dalla Strada
Non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi che contengono turpiloquio
- messaggi con contenuto razzista o sessista
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)