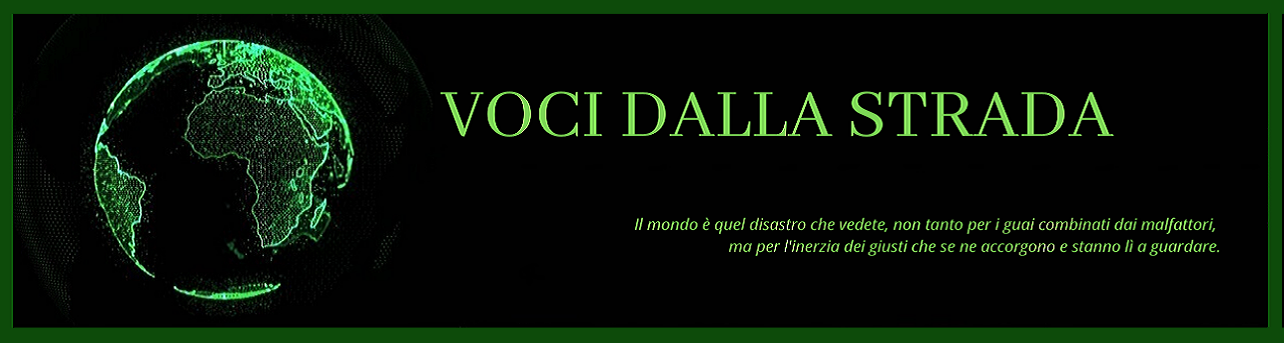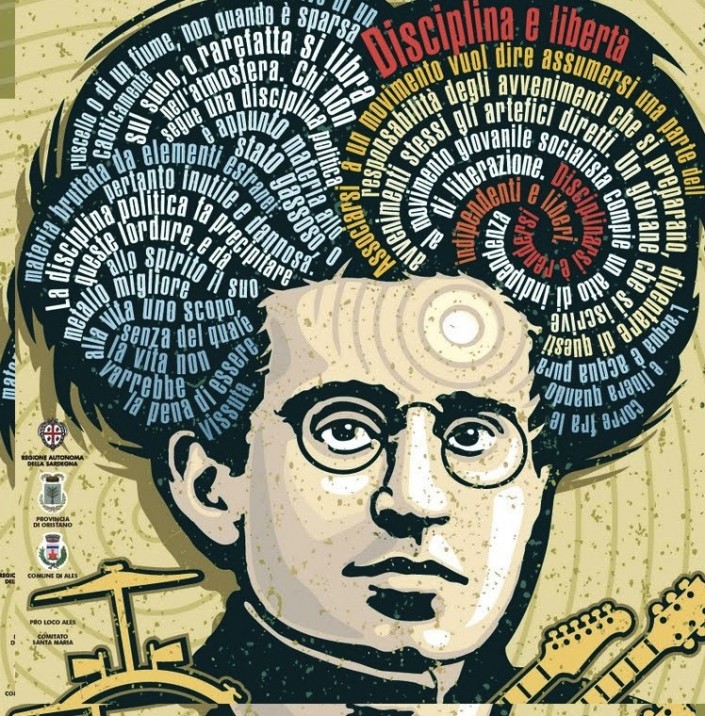Capitalismo o morte? In un'intervista pubblicata nel dicembre del 2019, il famoso marxista americano David Harvey ha reso assai chiaro, con una franchezza deprimente, in che cosa possa rapidamente degenerare la teoria di Marx, quando, dopo decenni, si continua ad ignorare in maniera sovrana la crisi sistemica, e di conseguenza non si dà forma ad un adeguato concetto di crisi [*1].
Rivoluzione? Una «fantasia comunista», oramai non viviamo più nel 19° secolo. Il capitale è «too big to fail», è diventato troppo necessario, e pertanto non possiamo permetterci il suo crollo. D'altra parte, le cose devono essere «mantenute in movimento», dal momento che in caso contrario «moriremmo quasi tutti di fame».