La fine dell'eccezione: per una lettura universalista e decoloniale della memoria della Shoah
Il genocidio perpetrato a Gaza rivela, con tragica brutalità, che la commemorazione dell'Olocausto non serve più necessariamente a prevenire tali orrori, ma talvolta a giustificarli. Lungi dal fare luce sul passato, la sua memoria sarebbe distorta per manipolare il presente.
Quasi tutti gli studiosi dell'Olocausto, che considerano qualsiasi critica nei confronti di Israele come un tradimento assoluto, si sono astenuti dal condannare le atrocità commesse a Gaza.
Nessuna delle istituzioni dedicate alla ricerca e alla memoria della Shoah ha stabilito i paralleli storici, pur evidenti, né ha denunciato il massacro dei palestinesi.Questo silenzio rivela, con poche eccezioni, il loro vero obiettivo: non studiare la natura umana e la sua terribile propensione al male, ma santificare gli ebrei come vittime eterne, assolvendo così lo Stato etno-nazionalista di Israele dai suoi crimini: colonialismo, apartheid e genocidio.
Strumentalizzando in questo modo l'Olocausto e rifiutando di difendere le vittime palestinesi solo per la loro identità, queste istituzioni e questi memoriali hanno perso ogni autorità morale. Ora sono pubblicamente denunciati come strumenti non di prevenzione, ma di perpetuazione del genocidio; non di esplorazione del passato, ma di manipolazione del presente.
Il minimo riconoscimento del fatto che la lezione dell'Olocausto non può essere appannaggio esclusivo di Israele e dei suoi sostenitori sionisti viene immediatamente censurato. Così, il Museo dell'Olocausto di Los Angeles ha rimosso un post su Instagram in cui si affermava: «MAI PIÙ» non può significare «MAI PIÙ» solo per gli ebrei, dopo aver suscitato vive proteste. Eppure è proprio questa interpretazione restrittiva che difendono i sionisti: mai più, ma solo per noi.
Già nel suo Discours sur le colonialisme (Discorso sul colonialismo), Aimé Césaire osservava che Hitler era stato percepito come eccezionalmente crudele solo perché praticava «l'umiliazione dell'uomo bianco», applicando all'Europa «le procedure colonialiste che, fino ad allora, erano state riservate solo agli arabi dell'Algeria, ai coolies dell'India e ai negri dell'Africa».
È questa stessa distorsione – rendere la Shoah un evento assolutamente unico – che turbava profondamente Primo Levi. Detenuto ad Auschwitz dal 1944 al 1945, autore di Se questo è un uomo e fervente oppositore dell'apartheid israeliana nei confronti dei palestinesi, considerava l'Olocausto una «fonte inesauribile di male» che si perpetua nei sopravvissuti loro malgrado, attraverso l'odio, il desiderio di vendetta, la decadenza morale o la rassegnazione. Deplorava il «manicheismo» di coloro che «rifiutano le sfumature e la complessità», «riducono il corso degli affari umani a conflitti, i conflitti a dualità, il “noi e loro”». Sottolineava che «la rete di relazioni umane all'interno dei campi di concentramento era complessa: non poteva essere ridotta a due categorie, quella delle vittime e quella dei carnefici». Sapeva che «il nemico è esterno, ma anche dentro di noi».
Levi prendeva ad esempio Mordechai Chaim Rumkowski, collaboratore ebreo che dirigeva il ghetto di Łódź. Soprannominato “il re Chaim”, trasformò il ghetto in un campo di lavoro forzato, arricchendosi mentre deportava i suoi oppositori nelle camere a gas e abusando sessualmente di molte donne. Per Levi, egli incarna ciò che ognuno di noi potrebbe diventare in circostanze simili. "Tutti noi abbiamo in noi qualcosa di Rumkowski, la sua ambiguità è nostra, come una seconda natura, quella degli ibridi fatti di argilla e spirito“, scrive in I sommersi e i salvati. "Ritorno ad Auschwitz".
«La sua follia è la nostra, la follia della civiltà occidentale che «si precipita all'inferno al suono delle trombe e dei tamburi». «Come Rumkowski, anche noi siamo accecati dal potere e dal prestigio, al punto da dimenticare la nostra fondamentale fragilità». «Volontariamente o meno, ci adagiamo nel potere, dimenticando che siamo tutti nel ghetto, che il ghetto è in stato d'assedio (...) e che i treni della morte sono pronti a partire».
Queste amare verità – che il confine tra vittima e carnefice è sottile, che siamo tutti potenziali carnefici e che non c'è alcuna moralità intrinseca nell'essere ebrei o sopravvissuti – sono proprio ciò che i sionisti cercano di occultare. Ecco perché Primo Levi era persona non grata in Israele.
L'emergere degli studi sull'Olocausto: tra dovere della memoria e strumentalizzazione
Lo sviluppo accademico degli studi sull'Olocausto, che ha conosciuto un significativo boom a partire dagli anni '70, si è progressivamente allontanato dalla sua iniziale vocazione universalistica. Questa disciplina, spesso incarnata dalla figura quasi santificata del fervente sionista Elie Wiesel (morto nel 2016) – definito dal critico letterario Alfred Kazin «il Gesù dell'Olocausto» –, avrebbe, secondo il testo, rinunciato a ogni pretesa di verità universale a favore di una narrazione particolaristica.
Come sottolinea lo studioso Norman Finkelstein, questi specialisti utilizzerebbero il riferimento all'Olocausto «non come una bussola morale, ma come uno strumento ideologico». Finkelstein arriva addirittura ad affermare che «vietare ogni paragone è il mantra dei racket della morale», denunciando così un tentativo di monopolizzare la sofferenza.
Per i sostenitori dell'ideologia sionista, l'Olocausto e l'esistenza dello Stato di Israele conferirebbero non solo un senso e una ragion d'essere, ma anche una superiorità morale spesso percepita come arrogante. Dopo la vittoria israeliana del 1967 e la conquista di Gaza e della Cisgiordania, questo Stato è diventato, per riprendere l'espressione di Nathan Glazer, «il credo degli ebrei americani», un pilastro identitario centrale.
Questo discorso si basa sul postulato discutibile che una sofferenza eccezionale conferisca diritti esclusivi. È questa visione distorta che sta alla base di ciò che Finkelstein chiama «l'industria dell'Olocausto». Lo storico Charles Maier, in The Unmasterable Past: History, Holocaust, and German National Identity, analizza questa dinamica:
«La sofferenza ebraica è descritta come indicibile, incomprensibile, ma che deve comunque continuare ad essere denunciata. Rimane intensamente intima (...) ma deve anche diventare pubblica attraverso musei e memoriali».
Maier solleva una questione cruciale:
«Quale deve essere il ruolo di un museo in un Paese come gli Stati Uniti, così lontano dal teatro dell'Olocausto? In quali circostanze un dolore soggettivo può fungere da lutto pubblico? ».
Questa domanda apre la porta a un confronto necessario: «E se il genocidio è riconosciuto come lutto pubblico, non dovremmo allora accettare i riferimenti ad altre sofferenze specifiche?», che si tratti della tratta degli schiavi neri, degli armeni, dei cambogiani o di altri gruppi perseguitati dal regime nazista.
Questa sacralizzazione della sofferenza ebraica ha conseguenze politiche dirette. Servirebbe a giustificare qualsiasi crimine commesso da Israele in nome della sua sopravvivenza e del suo «diritto all'esistenza», instaurando una visione manichea del mondo in cui ogni critica è assimilata all'antisemitismo e all'apologia del nazismo.
Questa strumentalizzazione andrebbe anche a vantaggio delle potenze coloniali desiderose di occultare i propri genocidi, che si tratti dello sterminio dei nativi americani, del genocidio armeno, della carestia in Bengala sotto il dominio britannico o delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Una domanda: il destino messianico di Israele è così diverso dal concetto nazista di Lebensraum?
Maier descrive uno «strano mercato di inganni»: l'Occidente, e in particolare la Germania, finanzierebbero e proteggerebbero Israele in cambio di un'assoluzione simbolica per i crimini commessi in passato contro gli ebrei. La Germania trarrebbe vantaggio da questa alleanza per dissociare il nazismo dal resto della sua storia coloniale, in particolare dal genocidio degli Herero e dei Nama in Namibia.
Lo storico israeliano Raz Segal, specialista in genocidi, vede in questa strumentalizzazione una pericolosa perpetuazione delle logiche che hanno portato all'Olocausto. «Una tale manipolazione», scrive, «legittima il razzismo nei confronti dei palestinesi proprio nel momento in cui lo Stato ebraico sta perpetrando un massacro contro di loro».
Segal, i cui familiari sono morti durante la Shoah, ha definito la situazione a Gaza «un caso da manuale di genocidio» già il 13 ottobre 2023, suscitando aspre critiche ma illustrando la profonda frattura che attraversa il mondo accademico riguardo all'uso politico della memoria dell'Olocausto.
La fine del monopolio della memoria: Gaza e il crollo dell'ordine internazionale
Per lo specialista israeliano Raz Segal, i segnali premonitori di un genocidio a Gaza erano innegabili. Egli ha percepito nella richiesta israeliana di evacuare il nord di Gaza e nella retorica disumanizzante dei leader (il ministro della Difesa Yoav Gallant ha affermato di combattere «animali umani») «il fetore nauseabondo del genocidio».
«Il principio stesso del “mai più” [...] consiste nel riconoscere i segnali precursori di un genocidio che devono spingerci ad agire per porre fine a un processo potenzialmente genocida, anche se non lo è ancora», spiegava Segal in un'intervista. Questa posizione, fondata sull'insegnamento stesso della Storia, gli è valsa pesanti sanzioni.
Ha persino suggerito che la fine degli «studi sull'Olocausto come campo di ricerca» non sarebbe «necessariamente una cosa negativa». Secondo lui, se questo campo è indissociabile «dall'ideologia della memoria mondiale dell'Olocausto», forse dovrebbe lasciare spazio «ad altre ricerche più interessanti e pertinenti sull'Olocausto come realtà storica».
Il suo coraggio gli è costato caro. La sua nomina a capo del Centro studi sull'Olocausto e il genocidio dell'Università del Minnesota è stata annullata, un'istituzione che a sua volta «non ha emesso alcuna condanna del genocidio».
Quasi due anni dopo l'inizio dell'offensiva, l'Associazione internazionale dei ricercatori sul genocidio ha finalmente pubblicato una dichiarazione in cui afferma che le azioni di Israele rispondono alla definizione giuridica di genocidio secondo la Convenzione delle Nazioni Unite. Un gesto tardivo che contrasta con il silenzio assordante della stragrande maggioranza degli studiosi dell'Olocausto. Questi ultimi, denuncia il testo, hanno condannato senza sosta gli attacchi di Hamas ignorando al contempo la portata delle atrocità israeliane, rimanendo in silenzio di fronte alla denuncia del Sudafrica alla Corte internazionale di giustizia e al rapporto schiacciante di Amnesty International.
Segal e i suoi coautori sottolineano nel Journal of Genocide Research l'esclusione sistematica delle voci palestinesi da questo campo di studio: «Quanti studenti palestinesi si iscrivono a programmi di studi superiori sull'Olocausto e il genocidio nel mondo? Generalmente nessuno». Quanti ricercatori palestinesi rivendicano lo status di specialisti in questo campo? Si possono contare sulle dita di una mano», scrive Segal in un articolo scritto a più mani e pubblicato sul Journal of Genocide Research.
Il crollo dell'ordine internazionale
La conclusione che se ne ricava è molto più ampia e severa: il genocidio sarebbe «inciso nel DNA dell'imperialismo occidentale», di cui la Palestina costituirebbe la prova più evidente. Esso rappresenterebbe la fase finale di quella che l'antropologo Arjun Appadurai definisce «una vasta revisione malthusiana del mondo», destinando il pianeta «ai vincitori della globalizzazione, senza il fastidioso fermento dei suoi vinti».
Finanziando e armando Israele, gli Stati Uniti e l'Europa avrebbero «fatto implodere l'ordine giuridico internazionale del dopoguerra». Questo ordine, costruito sulle rovine della Shoah e incarnato dall'ONU, non avrebbe «più alcuna credibilità». L'Occidente, conclude l'autore, «non è più in grado di dare lezioni a nessuno in materia di democrazia, diritti umani o presunte virtù della civiltà occidentale».
Gaza, epicentro di una nuova coscienza politica
Lo scrittore Pankaj Mishra, in The World After Gaza, vede nella devastata Striscia di Gaza il fondamento di una nuova coscienza mondiale. «Mentre Gaza dà le vertigini, instaurando il caos e il vuoto, diventa per tante popolazioni impotenti il fondamento essenziale della coscienza politica ed etica del XXI secolo», proprio come lo fu la Prima guerra mondiale per la generazione perduta.
La «finzione» secondo cui la Shoah sarebbe una tragedia esclusiva o conferirebbe diritti superiori non sarebbe più sostenibile. Il genocidio a Gaza annuncerebbe un nuovo ordine mondiale in cui l'Europa, gli Stati Uniti e il loro «mandatario», Israele, sarebbero relegati al rango di paria. Gaza avrebbe portato alla luce una verità funesta: la barbarie e la civiltà occidentale sarebbero una cosa sola. L'edificio morale del dopoguerra sarebbe crollato, rivelando la sua profonda ipocrisia e lasciando spazio a una nuova era, incerta e profondamente traumatizzata.
MOUNIR KILANI
Bibliografia
Appadurai, Arjun: antropologo e teorico della cultura indo-statunitense. «Una vasta revisione malthusiana del mondo».
Césaire, Aimé: poeta, politico e saggista martinicano, fondatore del concetto di «negritudine». «Discorso sul colonialismo»* (1950).
Finkelstein, Norman: Politologo statunitense. L'industria dell'Olocausto* (2000).
Glazer, Nathan: Sociologo statunitense.
Kazin, Alfred: critico letterario e storico della letteratura statunitense.
Levi, Primo: chimico e scrittore italiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Se questo è un uomo* (1947) e *I sommersi e i salvati* (1986).
Maier, Charles: storico statunitense, professore di storia all'Università di Harvard. The Unmasterable Past: History, Holocaust, and German National Identity* (1988).
Mishra, Pankaj: saggista e romanziere indiano. The World After Gaza*.
Rumkowski, Mordechai Chaim: capo del Consiglio ebraico (*Judenrat*) del ghetto di Łódź nominato dai nazisti.
Segal, Raz: storico israeliano, specialista dell'Olocausto e dei genocidi. Ex direttore del programma di studi sull'Olocausto e il genocidio presso l'Università di Stockton (New Jersey).
Wiesel, Elie: vincitore del Premio Nobel per la pace. Importante figura mediatica nella memoria dell'Olocausto.
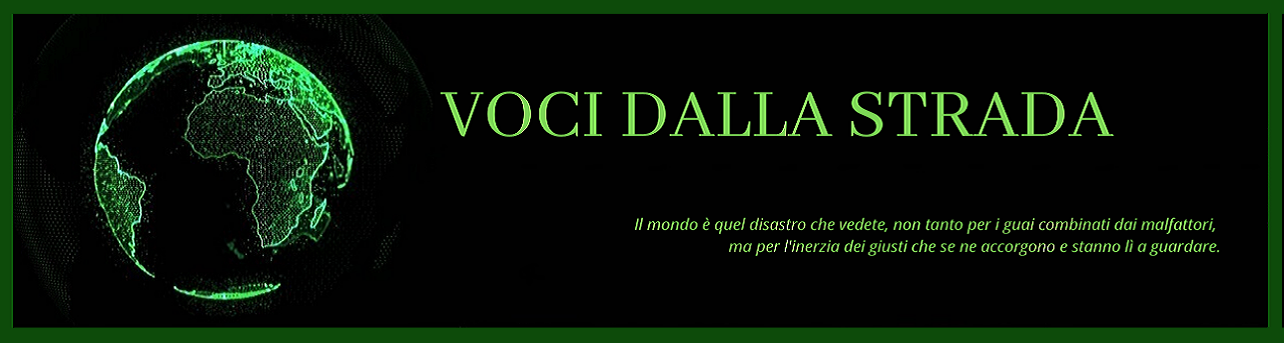

Nessun commento:
Posta un commento
Avvertenze da leggere prima di intervenire sul blog Voci Dalla Strada
Non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi che contengono turpiloquio
- messaggi con contenuto razzista o sessista
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)