foto di Francesco Cascioli http://www.ilpalo.com/
di Michel Husson
http://hussonet.free.fr/
La crisi greca è un terribile rivelatore di contraddizioni dell'integrazione europea. Una moneta comune presupponeva un alto grado di omogeneità tra i paesi interessati o il mettere in atto politiche ed istituzioni in grado di realizzare una tale uniformità. Tuttavia, nessuna di queste condizioni è stata soddisfatta. Al momento della creazione dell'euro, i paesi avevano modelli di crescita diversi: in alcuni paesi il principale motore della crescita era il mercato interno, mentre altri erano trainati dalle esportazioni. Alcuni paesi erano in una logica di recupero per l'effetto dell'inflazione a priori più elevata. Il risultato di questa configurazione apparve, anche prima della crisi, in forma di aumento della divergenza dei tassi di crescita, contrariamente alla convinzione che l'appartenenza a un mercato unico, dotato di una moneta unica, fosse di per sé un fattore di convergenza.
Tra il 1992 e il 2006, la crescita è stata in media del 3,1% all'anno nei paesi 'vincenti' (Spagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito, Svezia), cioè come gli Stati Uniti (3, 2%). Invece, non fu più dell' 1,6% nei paesi 'perdenti' (Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo).
Un processo di convergenza poteva essere sostenuto da una politica di armonizzazione delle condizioni fiscali e sociali delle attività economiche e la creazione di strumenti adeguati, ad esempio un bilancio europeo per finanziare i trasferimenti necessari per un'armonizzazione del genere. Ma l' opzione per un modo di costruzione liberale che privilegia la concorrenza "libera e non falsata" esclude a priori questo orientamento.
L'opzione per la moneta unica non è stata motivata dalla presunti benefici. La stabilizzazione del tasso di cambio si sarebbe ottenuto con dispositivi meno rigidi che consentono aggiustamenti periodici. L'euro è servito soprattutto per imporre la disciplina salariale: dato che era impossibile giocare con il tasso di cambio, i salari divennero l'unica variabile di aggiustamento. Ma questo non ha fornito alcuna soluzione alle divergenze delle traiettorie economiche nazionali. Due procedimenti hanno permesso di gestire queste tensioni fino alla crisi.
Il primo è stato, per alcuni paesi, di procedere ad una svalutazione in anticipo che ha permesso loro di entrare nell'euro con un tasso di cambio che assicurava una sorta di riserva di competitività. E' stato il percorso scelto da Spagna e Italia in particolare nella prima metà degli anni 1990. E nella direzione opposta, paesi come la Francia (e anche in qualche misura la Germania), sono entrati nell'euro ad un tasso di cambio sfavorevole, in termini di competitività.
Il secondo fattore di flessibilità corrisponde all'unico beneficio dell'euro: il disavanzo estero di un paese non influisce sulla propria moneta in quanto non ne hanno più. Complessivamente il commercio estero della zona euro è più o meno equilibrato, e il problema dell' euro era piuttosto, nell' ultimo periodo, essere troppo forte rispetto al dollaro. Questa protezione fornita dall'euro ha permesso ad un certo numero di paesi di ottenere una crescita elevata sulla base di un crescente deficit estero. La moneta unica garantiva inoltre una relativa omogeneità dei tassi di interesse, specialmente per quanto riguarda il finanziamento del debito pubblico.
Questa configurazione non era sostenibile. La crisi ha accelerato brutalmente i processi e la speculazione finanziaria ha portato alla luce del giorno, le tensioni inerenti all' Europa neoliberale. Ma la polarizzazione dei paesi della zona euro in due gruppi esisteva prima della crisi: da un lato, Germania, Paesi Bassi e Austria hanno goduto di sostanziali eccedenze commerciali e il loro deficit è rimasto moderato. D'altra parte, c' erano già famosi "PIGS" (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna) in una situazione inversa: deficit commerciale e disavanzo pubblico già sopra la media. Belgio, Francia, Italia e Finlandia occupavano una posizione centrale.
Con la crisi, questa polarizzazione si è accentuata: i disavanzi pubblici sono aumentati in tutto il mondo, ma molto meno nel primo gruppo di paesi (Germania, Paesi Bassi, Austria), che mantengono eccedenze commerciali. In tutti gli altri paesi, la situazione si sta deteriorando con l'esplosione del deficit pubblico e di un crescente squilibrio nella bilancia commerciale.
Oggi la Germania vuole imporre la logica brutale dell'euro, perché tutti i mezzi che consentano di sfuggire ad essa ora sono esauriti. I paesi più colpiti dalla crisi dovrebbero attuare piani di adeguamento. La sottomissione delle autorità europee ai mercati finanziari è totale e la Grecia è un laboratorio di politiche di austerità che i governi metteranno in marcia in tutta Europa.
Questa politica è un suicidio e non può che condurre ad una nuova recessione. I piani di adeguamento ovviamente rompere la domanda interna e la Germania non può compensare la perdita dei mercati in Europa, con un aumento delle esportazioni verso il resto del mondo. La situazione può portare alcuni Paesi a lasciare l'euro al fine di trovare un margine di manovra giocando con il suo tasso di cambio. Ma è una soluzione disperata che potrebbe innescare una spirale recessiva e innescare la speculazione che nessuno cerca di inquadrare.
Ci sono comunque delle alternative che tengono conto degli squilibri strutturali tra le economie nazionali e implicano una riformulazione dei principi della costruzione europea.
• La speculazione finanziaria deve (e può) essere immediatamente scoraggiata, introducendo una tassa sulle transazioni finanziarie. Dobbiamo andare verso la "messa fuori legge", per esempio vietando il mercato dei CDS (Credit Default Swaps), che sviluppa la speculazione in titoli del debito pubblico, e ogni forma di "vendite scoperto".
• Gli Stati non dovrebbero più finanziare il loro debito con i mercati finanziari, ma con la Banca centrale europea, con l'obbligo per le banche di avere un importo minimo di titoli del debito pubblico, allo stesso tasso di rifinanziamento di cui esse beneficiano.
• Il principio di armonizzazione deve sostituire quello della concorrenza con la creazione di un fondo europeo di armonizzazione finanziato da una tassazione unitaria del capitale. Tendría por objeto realizar la convergencia hacia arriba de los derechos sociales en Europa. Ciò al fine di rendere la convergenza dei diritti sociali in Europa.
• Una vera soluzione alla crisi implica il ritorno alla piena occupazione e passa attraverso la creazione diretta di di posti di lavoro socialmente ed ecologicamente utili e attraverso la riduzione dell'orario di lavoro. Su questi due punti, l'Europa può essere un motore, lanciando programmi di investimento coordinati, e stabilendo norme sociali comuni.
Tutto questo è possibile e razionale ma completamente opposto al Trattato di Lisbona e alla logica capitalista, indurita ulteriormente dalla crisi. Le reazioni alla crisi greca dimostrano l'incapacità dei governi borghesi di definire una politica di cooperazione, e questa cecità conduce direttamente al caos. In queste condizioni, l'unica ipotesi strategica plausibile è quella dell' esplosione popolare di resistenza ai piani di austerità, che faranno emergere la necessità di un' Europa solidale.
Articoli correlati:
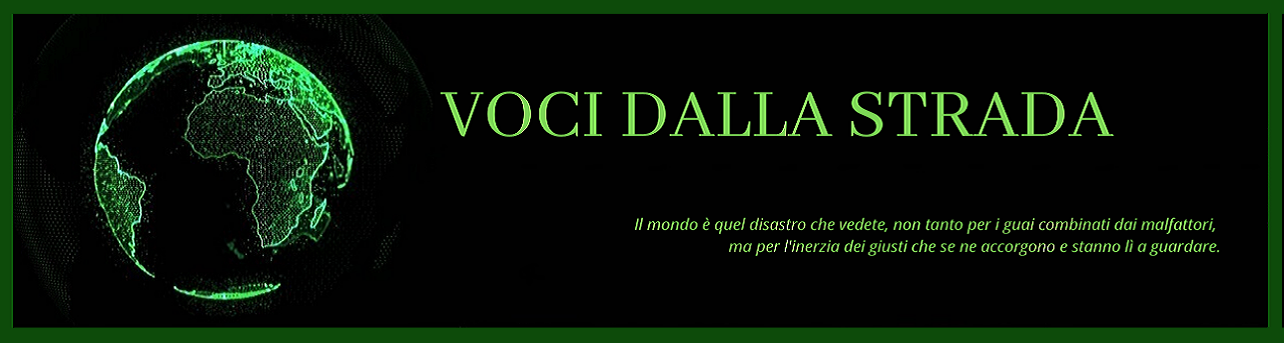

Scusami, l'Italia era tra i pasei 'perdenti' o 'vincenti'? Perché per errore nel post è stata riportata in entrambi.
RispondiEliminaChiedo scusa, è stato un mio errore mettere l'Italia in entrambe le categorie, ho appena corretto (grazie per la segnalazione).
RispondiEliminaOvviamente l'Italia è tra i paesi PERDENTI, poteva essere altrimenti?
;)